Le Antichità di Alma (appuntamento n°12)
- Martina Toppi

- 28 lug 2025
- Tempo di lettura: 9 min
«Un’ascesa parallela a quella santa»: recensione di Non per il mondo, ma per il giardino di Mikel Marini tra le rane di Aristofane e le api di Virgilio
San Prescazio, mastro Balasi, Bedoier, Contradiòs, Plinpalàn, Gòlomorz, Semoléd, Carnibél, farfalle, rane pescatrici, allevatori di perle, rospi e Veneri formose, santi ed eremiti, maghi ed eroi con dame tormentate: sono tutti i personaggi che si incontrano nella catabasi di Mikel Marini. Non per il mondo, ma per il giardino (Vallecchi Poesia, 2024) è il viaggio tramite cui il poeta, ora solo nel deserto, incantato dalle illusioni prodotte dalla sua stessa mente, ora ombra tra le ombre di un’umanità che vive e brulica consumandosi reciprocamente per continuare a esistere nel gioco della quotidianità, scende nelle profondità oscure della scrittura e dell’esistenza. I versi raccolti in quest’opera sono un riflesso di riflessi di altre storie - storie dell’antichità classica, dell’epica bretone, spirituali, ma anche dissacranti -, tutte scritte «ingemmando tradizioni copiosissime di errori» in cui è facile perdersi dimenticando chi sia più reale tra Contradiòs, un eroe da commedia, e San Prescazio, che cerca uno spazio in cui esistere tra la sabbia delle dune.
L’opera prima di Marini è come il sogno di Alice nel Paese delle Meraviglie che nella sezione centrale trova un punto nevralgico intorno a cui ruota il caos dell’invenzione più pura. Marini non resiste all’ispirazione che gli deriva da studi e letture: accetta tutto, tutto mette su carta e lì «tutto si fa candela, tutto andrà in combustione». Ogni storia e leggenda che il lettore ritrova nelle sue poesie ne echeggia decine di altre in un ri-utilizzo continuo di topoi già narrati da altri. Proprio come la danza di Capitan Libeccio e degli altri uccelli nell’adattamento disneyano della storia di Lewis Carroll (quando Alice è travolta nella “maratonda” incomprensibile che gli animali ballano sulla spiaggia), così i riferimenti letterari di Marini girano in tondo su sé stessi, trovando però un unico centro. Quel centro di verità che il poeta prova a riportare in superficie in ogni componimento: «Così discendo cieco lisicio, luminoso, / nel mondo del silenzio dove tutto è immobile / e si deposita purissimo / il residuo più essenziale di quant’è nell’universo».
Scrive Isabella Leardini nella prefazione dell’opera: «Non per il mondo ma per il giardino è un labirinto di epoche e figure imprevedibili, sposta continuamente il confine tra letteratura e immaginazione, con la provocazione della farsa affonda in una prodigiosa originalità di pensiero. È un libro attraversato dalla violenza della mistica, in cui il mostruoso è meraviglioso e la penitenza è trasformazione».
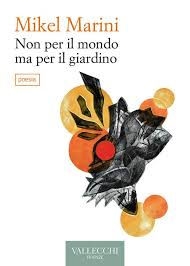
Ogni lettore dunque può scegliere quale dei tanti fili narrativi a disposizione tirare per trovare la strada che conduca fuori dal labirinto mostruoso, ma nel senso latino del termine, ovvero prodigioso, di Marini. La catabasi di Dioniso nelle Rane di Aristofane è il primo che qui pare opportuno. Mai esplicitamente citata da Marini, la commedia ateniese sembra però un riferimento sotteso e utile però per specchiare il viaggio del poeta negli Inferi, tra creature bizzarre della notte e prodigi della fantasia.
CARONTE: «Smetti di fare il buffone: punta i piedi e rema forte.»
DIONISO: «E come faccio? Non ho mai provato, non sono un uomo di mare, non vengo da Salamina.»
CARONTE: È facilissimo. Sentirai degli splendidi canti, non appena ti metti a spingere.»
DIONISO: «Di chi?»
CARONTE: «Di rane cigni, una meraviglia.» (Le Rane, Aristofane, vv. 201-205, a edizione cura di Dario Del Corno, Fondazione Lorenzo Valla 1985)
Come un pigro e fifone Dioniso comico, Marini si finge eroe tra le rane, creature liminari tra il mondo dei vivi, che lavorano alacremente per dare un senso all’esistenza, e il mondo dei morti, quello delle idee irrazionali che galleggiano negli abissi dell’immaginazione attraversando luoghi ed epoche per dare forma a una coscienza collettiva che la letteratura riesuma in continuazione.
ESCHILO «Questi sono gli effetti a cui deve badare un uomo che fa poesia. Considera come sono stati utili fin da principio i poeti di valore. Orfeo ci insegnò i sacri riti e a non spargere sangue, Museo le cure delle malattie e gli oracoli, Esiodo il lavoro della terra, le stagioni dei prodotti, l’aratura; e perché ottenne onore e fama il divino Omero, se non per avere insegnato tante cose utili, l’arte di schierarsi e le prodezze e l’armamento dei guerrieri?» (Le Rane, Aristofane, vv. 1030-1035)
Ma la discesa negli inferi non è solo commedia e gusto del grottesco. Per Aristofane lo scopo è molto serio: Dioniso viene spedito nell’adildà in cerca di un poeta che possa salvare il teatro ateniese. Chi andrà riportato in vita tra l’epico Eschilo e l’innovatore Euripide? La domanda attraversa la commedia, densa di riferimenti politici e culturali all’Atene di allora, calata nel proprio tempo e al tempo stesso eterna.
CORO: «e se ne torna a casa
per il bene dei cittadini,
per il bene dei suoi
parenti e amici
perché è intelligente.
È bello non fare chiacchiere
seduti insieme a Socrate,
spregiando la poesia
e trascurando i sommi princìpi
dell’arte tragica.
Con discorsi solenni
e insulse futilità
passare inerti il tempo
è da uomo dissennato» (vv. 1486-1499)
Anche nella raccolta di Marini c’è una sezione in cui il tono della discesa agli inferi si fa più serio. In “Alveare”, Marini elegge come protagoniste le api. La sezione ne segue altre due dedicate a specifici personaggi frutto dell’immaginazione dell’autore - San Prescazio e Giovanni del deserto -, di cui Marini racconta peripezie e quotidiane scoperte isolandoli da un mondo vorticoso e confusionario che lui stesso ha creato, senza però che i due riescano a dare a quel mondo un senso.
“Alveare” invece a quel mondo rimette ordine: qui il poeta lascia da parte il tono ironico e il sorriso beffardo che ne ha mascherato il viso per tutti i componimenti precedenti e affonda la poesia nella descrizione di un mondo perfetto in cui «tutto è diretto in un modo o in un altro a disfarsi / poi assumere forme compatte, ed è un dono / che non scuote il genoma, che invece lo fissa, / un punto nero dove splendi e il dono implode». L’alveare è il mondo dell’uomo, dove a ognuno è assegnato il ruolo da svolgere per garantire la prosecuzione della vita e della società stessa. Un «favo nero», così lo descrive Marini, formato dal sacrificio di ciascun individuo. Per dargli forma ogni ape deve dare qualcosa di sé «le ghiandole spremendosi l’addome, perfetto / bronchìolo di polmone dentro il miele: / al buio / c’era un grande ordine di forme». Il favo nero è il fondo della catabasi, il punto di arrivo della discesa delirante ma è anche il vertice dell’estasi, tema sotteso alle sezioni successive della raccolta. La discesa consente di comprendere, di elevarsi e vedere con chiarezza il senso: «tutto si fa candela, tutto andrà in combustione, / tu che non brilli ma ti sfasci nella cera».
Di qui prendono il via le altre avventure cui l’autore decide di dare forma al suo mondo: un continuo rimescolarsi di miti, magie, imprese di cavalieri, sempre più tendenti al faceto che al serio. È la verità scorta nell’estasi che richiede di esplorare, di cercare ovunque. Ed è una verità che a più riprese emerge nei versi: «sembra che solo / sul punto di sparire potrai esserci per sempre», scrive Marini introducendo il personaggio del copista dal nome storpiato che trascrive le storie commettendo errori insanabili sui manoscritti. Scrive ancora Marini, raccontando l’avventura di Beodier, il servo che si occupa del cibo servito a tavola alla corte di Artù e descrivendo la macabra scena di una tavola di commensali che si mangiano a vicenda: «io credo che a questo punto / si potrebbe capire qualcosa / grazie a questa collana di mani in bocca / e pugni fino al gomito nei piatti». E ancora, questa volta narrando un torneo in cui sono coinvolti gli amici di un altro protagonista della raccolta, il cavaliere Contradiòs, la verità scorta nella discesa torna a farsi luminosa: «L’avventura allora era qualcosa / di molto simile a un fatto come questo, / io penso a che pensarono quei cinque, / che vivere per sempre / vuol dire far morire tutto il resto».
Ma è solo più avanti nella raccolta che la verità scovata nell’oscurità si presenta in tutta la sua luminosa presenza e si fissa nella mente del lettore. Avviene quando il poeta cala sé stesso nel caos dei versi. Thomas Doughty, il suo alter ego, è un nobile inglese che prese parte alla spedizione intorno al globo di Francis Drake. Condannato a morte e decapitato, il destino del suo cadavere, raccontato dalla sua stessa voce, è quello di trasformarsi in una carcassa marina. Una carcassa la cui sorte, scrive Marini, è la stessa degli organismi coinvolti in un disastro ecologico realmente avvenuto, nel 2020, al largo della penisola russa di Kamchatka: come il corpo di Doughty si ricopre di conchiglie, alghe, scafopodi, così accade a tutte le creature marine rimaneggiate dalla schiuma dell’oceano fino a trasformarsi in altro. «Poi presto avrebbero detto / che sarebbe stato un disastro: / ma per qualche tempo in quel luogo / anche di giorno fu colma la riva / di biancheggianti stelle marine».
Per capire quanto accade all’alter ego di Marini occorre tirare un altro filo dell’arazzo e chiedere aiuto a un secondo testo classico. Il cadavere che diventa creatura marina subisce una bugonia, come quella narrata da Virgilio nel IV libro delle Georgiche, in cui il poeta affronta il tema dell’apicoltura. Nell’antichità le api erano ammirate per svariati motivi: per il mistero che allora ne avvolgeva il ciclo biologico (l’ape operaia è sterile e la castità delle api avvalorava agli occhi degli antichi la natura superiore di questi animali), per la fedeltà dimostrata dallo sciame alla regina (identificata però nelle Georgiche in maschile, come rex) e, non da ultimo, per il forte senso di comunità e per i rigidi ruoli gerarchici che caratterizzano la vita all’interno dell’alveare. La vita delle api diventa, nella prima metà del IV libro delle Georgiche, metafora della vita umana come modello di purezza e di virtù civica. Ma è nella seconda metà del libro che si può trovare la chiave di volta per aprire le porte più volte suggerite da Marini nella sua raccolta.
La società dell’alveare è perfetta e irriproducibile per l’uomo, priva del desiderio sessuale e della passione amorosa che contraddistinguono la sofferenza e l’esistenza umana. Uno squilibrio incarnato da Virgilio nel mito di Orfeo e di Aristeo. Aristeo è il responsabile della morte di Euridice, amata da Orfeo: preso dal desiderio di lei la insegue, la fanciulla fugge, fuggendo viene morsa da un serpente e muore. Orfeo, pur di riaverla, è disposto a scendere fin negli inferi dove gli viene rivelato l’unico modo per riportarla in superficie con sé: rinunciare al desiderio di lei, risalire le oscure vie dell’aldilà senza voltarsi mai a guardarla, per assicurarsi che lei stia camminando con lui. Orfeo non è ape ma uomo e a quel desiderio non può rinunciare, così come è noto si volta, vede Euridice e la perde per sempre.
Alla fine però è la figura di Aristeo che conta, l’apicoltore che non riesce a tenere in vita le proprie api e invoca gli dei per capire come fare. Scoperto che la ragione della moria di api è la sua colpa nei confronti di Euridice, Aristeo si fida e segue scrupolosamente le indicazioni ricevute dal dio Proteo e della madre: sacrifica quattro tori, compie il rito purificatorio ed ecco…
«Ed ecco che qui, improvviso, mirabile a dirsi, un prodigio contemplano: per le carni putrefatte dei buoi entro tutto il ventre ronzano le api e ribollono fuori dai fianchi spezzati, e immense nubi si estendono, e già si raccolgono sulla cima di un albero, calano il loro grappolo dai flessibili rami» (vv. 528-558) traduzione in prosa di Alessandro Barchiesi, Mondadori).
L’episodio è noto come bugonia e mostra la generazione spontanea della vita dalla morte. La stessa che in più occasione Marini fa emergere dai propri versi, facendo del proprio alter ego materia stessa di bugonia: è questo che accade quando dal cadavere di Thomas Doughty immerso negli abissi nasce una creatura marina. Ed è per questo che Thomas Doughty verso la fine dell’opera di Marini si domanda: «Perché soltanto il limite descrive / la soglia del miracolo a cui fai da testimone?». Lì dove il limite è l’estremità della coscienza umana toccata dal poeta proprio grazie all’ascesi compiuta, che è stata discesa, morte, putrefazione e poi miracolosa rinascita dalla carcassa. La risposta alla domanda però, nonostante Marini sembri trovarla quando scrive «Non posso mondo / non posso detestarti perché penso / a quanto sei gentile e disponibile / che non consentirai / che il posto che ho occupato abbia un suo peso / ma lo ricolmerai di meraviglie / a piacimento, neanche una lacuna / minuscola senza che sia risolta», come ogni verità messa in luce dalla poesia richiede a ciascuno la medesima discesa agli inferi delle Rane di Aristofane e la comprensione della contrapposizione tra Orfeo e Aristeo e di quel miracolo delle api nate dalla morte che è disvelato nelle Georgiche di Virgilio.
L’ARRIVEDERCI DI KALANOS (Mikel Marini)
Ci incontreremo ancora a Babilonia,
indicandoci a vicenda nei giardini;
con le scapole e le piume
si apriranno le fessure sulle schiene
di ceramica e mattoni, le clavicole,
più lontane delle spalle,
ne usciranno strette ai calami e alle penne.
Ci incontreremo, allora, a Babilonia
dove anche le creature più tremende sono alate,
e dove le farfalle, gli occhi accesi e colorati,
rivestono di ali le terrazze,
e prenderemo il volo coi palazzi
le biblioteche con le tavole d’argilla:
non lasceremo indietro
che le torri a sette piani tese contro il sole,
un vecchio nido di serpenti
che si accalca e striscia in alto disperdendo
sui gradoni qualche squama, il risultato
della muta
di un’ascesa parallela a quella santa.

Mikel Marini è nato a Bilbao nel 2000, è trilingue, studia Italianistica all’Università di Bologna. Fa parte del Direttivo del Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. È redattore del lit blog Vallecchi Poesia e di Inverso – Giornale di Poesia. Alcune poesie dal suo esordio Non per il mondo ma per il giardino (Vallecchi, 2024) sono comparse sul numero 28 di «Poesia» (Crocetti Editore). È stato incluso nel progetto Over-dose a cura di Giovanni Turria.




Commenti