Editoriale Poesia & Rete (appuntamento n°14)
- Alessandra Corbetta

- 5 nov 2024
- Tempo di lettura: 6 min
Continua, con questo quattordicesimo incontro, l'editoriale su Poesia & Rete, a cura di Alessandra Corbetta, un progetto trasversale alle pubblicazioni del blog che proverà a monitorare, attraverso interventi di diversa natura, lo stato delle interrelazioni tra il linguaggio poetico e le dinamiche del Web.
Chi volesse segnalarci studi o ricerche su questo argomento o desiderasse contribuire ad arricchire con competenza il dibattito, può farlo scrivendo a redazione@almapoesia.it, specificando in oggetto “Editoriale Poesia & Rete”; tutto il materiale pervenuto verrà sottoposto a lettura e quello ritenuto più interessante e valevole verrà proposto all’interno del progetto.
L'ospite di oggi è Massimo Maggiore, che ci regala un interessante articolo dedicato a poesia, diritto d'autore e intelligenza artificiale.

CREATIVITA' E INTELLIGENZA ARTIFICIALE SECONDO LA LEGGE SUL COPYRIGHT: È POSSIBILE LA POESIA SENZA POETI?
Non è facile definire l’intelligenza artificiale, anche se diversi tentativi sono stati fatti, fino ad arrivare alla definizione che si trova nel recentissimo Regolamento Europeo (cosiddetto AI Act). Semanticamente, l’aggettivo “artificiale” accostato a quello di “intelligenza”, vuole trasporre nell’ambito dell’automazione dei computer un attributo squisitamente umano, quello appunto dell’intelligenza. Tanto secondo un processo tipico di antropomorfizzazione di concetti nuovi, soprattutto nel campo digitale, per renderli più comprensibili. Come è stato osservato, usare il termine intelligenza (artificiale) è però una scorciatoia: meglio sarebbe parlare di “nuova forma dell’agire”. I sistemi di intelligenza artificiale riescono infatti a compiere determinate operazioni che emulano quelle umane, in modo molto più efficace e veloce, senza presupporre intelligenza. Il processo incentrato sul risultato (output) che caratterizza i sistemi di AI tende semmai a dimostrare non l’intelligenza del sistema stesso, bensì la sua capacità di sostituirsi all’intelligenza umana. Significativamente Alan Turing, il padre della scienza dei computer moderna, chiedendosi se le macchine possano pensare, sin dagli anni 50 parlava di “gioco dell’imitazione” delle macchine rispetto alle capacità cognitive umane, ma non di intelligenza, se non nel titolo del suo celeberrimo articolo Computing Machinery and Intelligence.
La stessa intelligenza umana è di non semplice definizione. Intelligenza in un’ottica squisitamente umanitaristica richiama a mio avviso il concetto di (auto)coscienza. La capacità di sentir(si) e percepirsi come esseri nel mondo e in relazione spazio-temporale con il mondo, attraverso il corpo. A questa stregua, ritengo che un elemento centrale di questa definizione del “cogito”, come contenuto dell’intelligenza umana, sia data dalla consapevolezza del proprio destino mortale. In un’ottica di creazione poetica, si potrebbe dire che nel poeta il pathos precede il logos e, pertanto, elemento fondante della creazione poetica è quello di dare voce all’inconscio più profondo. Le macchine come noto non patiscono, non hanno sensi e non dispongono di un inconscio.
La connessione profonda tra la creazione poetica e l’essere umano-poeta assume un rilievo specifico sul piano legale. Anzi, può forse sorprendere constatare come sia proprio la legge a porsi in una prospettiva di valorizzazione della creatività, come oggetto meritevole di tutela, solo se e in quanto riconducibile a un essere umano. In particolare, con riguardo all’uso delle tecnologie dell’IA, si pone una domanda di particolare rilievo: chi sia l’autore di una poesia creata dall’intelligenza artificiale e se quel testo sia meritevole di tutela legale in base alla legge sul diritto d’autore (copyright). È proprio la legge sul diritto d’autore (in Italia la Legge 631 del 1941) lo strumento che ci consente di dire cosa debba intendersi per “autore”. Esso è definito quale il “creatore” di “opere dell’ingegno di carattere creativo”, tra le quali quelle della letteratura. La definizione è pregnante, perché da essa derivano una serie di conseguenze giuridiche fondamentali, che ci consentono anche di rispondere al secondo quesito, ossia se la poesia prodotta dall’IA sia tutelata col copyright. Nella legge, infatti, il concetto di autore e il concetto di opera tutelabile, in quanto scaturita dal primo, sono strettamente interdipendenti.
Analizzare tutte le sfaccettature della questione che ho posto sarebbe un esercizio quanto mai complesso. In un contesto tuttavia in cui i sistemi di IA generativa (GAI), basati sui large language models (LLM), sbalordiscono, quantomeno per l’efficacia che sul piano dell’apparenza formale dimostrano nel gioco dell’imitazione dell’atto di “creare” (temine che come si vedrà va usato con estrema circospezione) testi poetici, rispondendo a prompt dell’utente, in questo contesto – si diceva – un giurista, ma in realtà chiunque si occupi di creatività poetica, non può non chiedersi se quei testi generati dall’IA acquisiscano dignità di “opere dell’ingegno a carattere creativo” protette dalla legge.
La legge d’autore italiana ha abbracciato un approccio di tipo personalistico-soggettivo, che valorizza la tutela dell’opera dell’ingegno quale manifestazione della personalità dell’autore, contrapposto a quelli di tipo utilitaristico-oggettivo (tutela dell’opera perché semplicemente fruibile in quanto tale o perché frutto di investimento di risorse) ovvero epistemologico. Posso qui subito anticipare che nell’attuale sistema normativo italiano - ma la situazione non è molto diversa in molte altre parti del mondo - la possibilità di accordare la tutela d’autore alle opere prodotte dall’IA sostanzialmente non sussiste. La legge d’autore, infatti, è senza dubbio, almeno nella sua conformazione attuale, una legge antropocentrica. A questa stregua, il discrimine tra un’opera proteggibile e una che non lo sia, non risiede affatto nella qualità artistica del manufatto poetico. Anche i versi più banali, purché non rappresentino una mera riproduzione di versi altrui, sono proteggibili. Se pertanto la soglia di accesso alla protezione prescinde dalla qualità artistica, se ne dovrebbe concludere che anche le opere generate dall’IA siano proteggibili. Così non è tuttavia, perché l’elemento veramente qualificante su cui si incardina il beneficio della protezione è rappresentato dall’essere l’opera “particolare espressione del lavoro intellettuale”, ovvero secondo le corti dell’UE, “creazione intellettuale propria dell’autore” (author’s own intellectual creation). In questa configurazione del presupposto giuridico, un’opera sarà dunque protetta se porti in sé l’impronta della personalità e dell’intelletto proprio dell’autore. Le macchine non possiedono né personalità, né, per i motivi accennati all’inizio, intelletto.
Ne consegue che un’opera la cui creazione sia interamente delegata dall’utente all’IA, ad esempio attraverso un semplice input-prompt iniziale come “componi una poesia in stile ermetico”, non sarà meritevole di tutela in base al diritto d’autore. A ben vedere, in questo caso non si potrà neanche parlare di creazione in senso legale, ma di semplice produzione, o rilascio di un output non creativo, tanto più che esso dipende dal modello di linguaggio sottostante che “tokenizza” le decine di migliaia di parole presenti nel database e li ricombina, secondo una funzione sostanzialmente statistica: quanto è probabile che alla parola X segua la parola Y. Il risultato come si è detto può essere anche sbalorditivo all’apparenza, ma mancante del tutto del nesso causale tra tale testo poetico e le scelte creative dell’utente che ha dato il prompt (o se si vuole tra testo e “ispirazione”), sicché nessuna tutela del copyright potrà essere accordata, tenuto conto del parametro normativo della creazione intellettuale propria dell’autore. Tradotto in termini più poetico-filosofici, ci sarebbe il logos ma non il pathos.
Non è da escludere peraltro che, attraverso un procedimento di raffinazione progressiva di input-prompt successivamente immessi nel sistema di IA per personalizzare il testo iniziale non si possa poi riconoscere un sufficiente livello di selezione creativa in capo all’utente del sistema, tale da attribuire nuovamente centralità alla figura dell’utente-essere umano come scaturigine dell’opera che, quindi, risulterebbe protetta. In tal caso, infatti, il sistema di IA potrebbe tornare a configurarsi come un semplice “mediatore” del processo creativo, come ad esempio una macchina fotografica, senza assorbire il processo creativo umano e sostituirsi ad esso. Tuttavia, onde poterlo affermare in concreto, occorrerebbe avere contezza dei prompt progressivi di raffinazione del testo, che dovrebbero a mio parere lasciar comunque intravvedere l’intenzione poetica personale dell’utente sottesa al testo e non peccare dunque di vaghezza e genericità, come nell’esempio del prompt di partenza richiamato sopra.

Massimo vive dal 1990 a Milano, dove si trasferì dal Salento per studiare Giurisprudenza presso l’Università Cattolica. Lavora come avvocato dal 1997. Scrive poesia dall’età di 23 anni circa, ma fino a poco tempo fa lo ha fatto esclusivamente per se stesso, come esercizio di riflessione interiore, spinto dal suo amore per la letteratura e la filosofia. Questo fino a che, nel 2021, non ha frequentato due corsi di poesia alla Scuola Holden (era il regalo del suo cinquantennio), che gli hanno fatto comprendere che una poesia non esiste fino a che non si offra agli altri e non sia detta. Pubblica quindi la sua prima silloge nel 2023 con Porto Seguro, dal titolo “Variazioni (su) conoscenza, amore e tempo”, come summa di testi scritti tra il 2020 e l’inizio del 2022. I temi su cui si incentra tutta la sua riflessione e il suo universo poetico riguardano il tempo, la memoria e – come derivazione dei primi due – l’oscillazione tra il divenire e l’eterno come destini e ambienti possibili dell’essere umano. La sua ultima pubblicazione in versi è Il ritrovamento del corpo (Manni Editore, 2024)

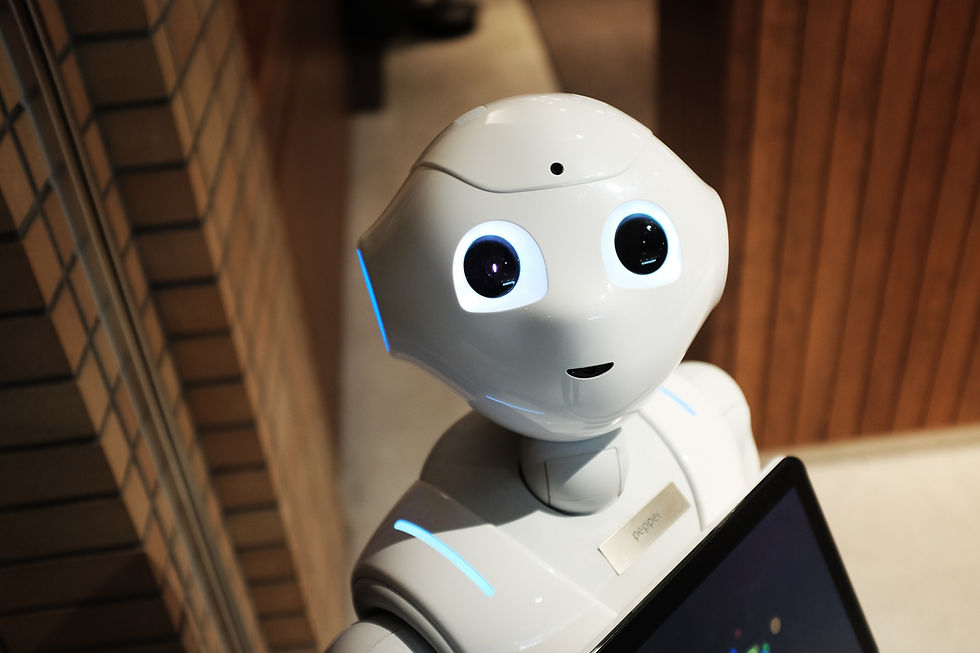

Commenti